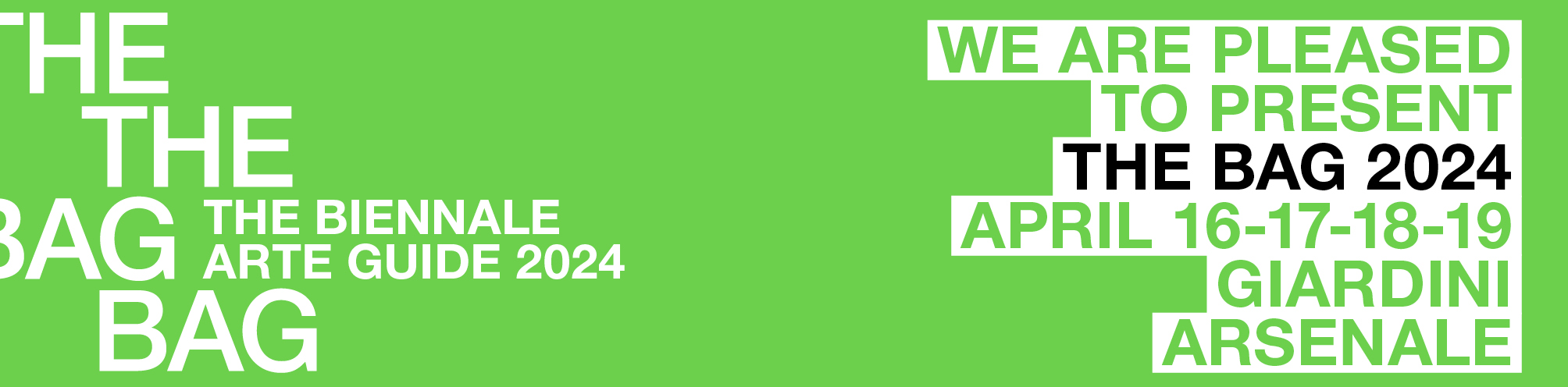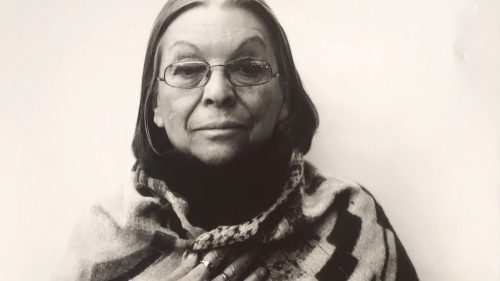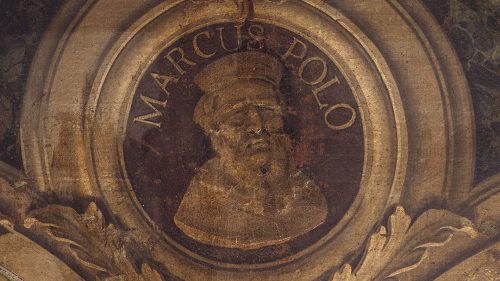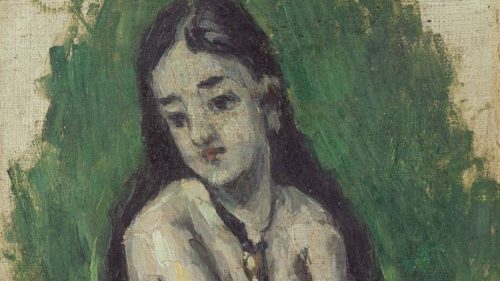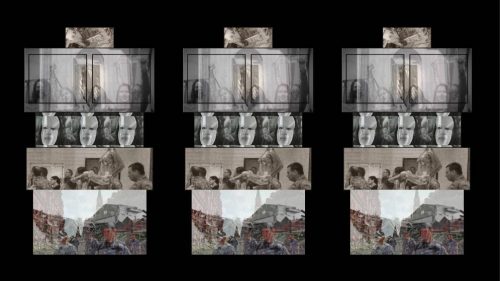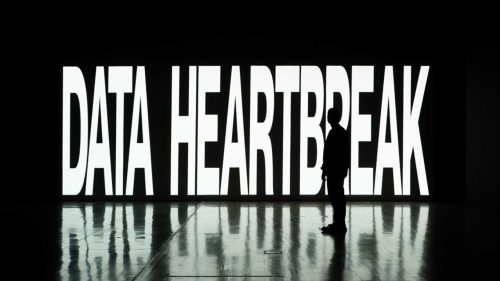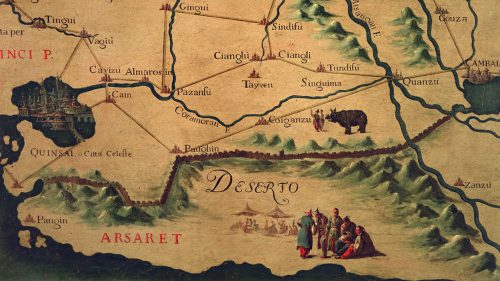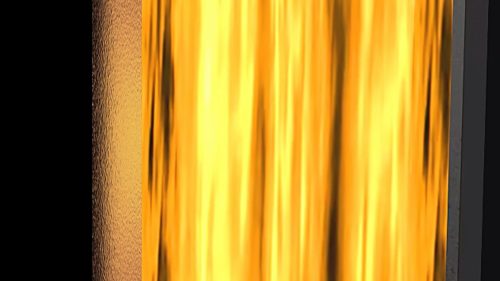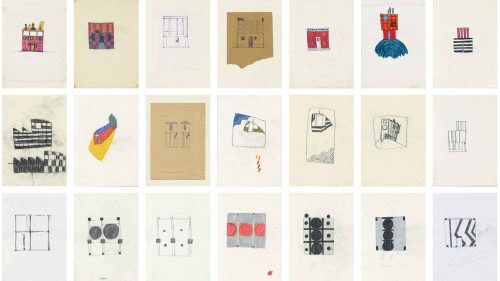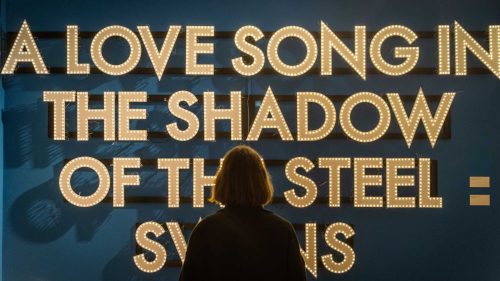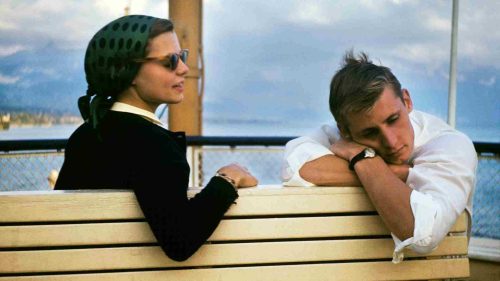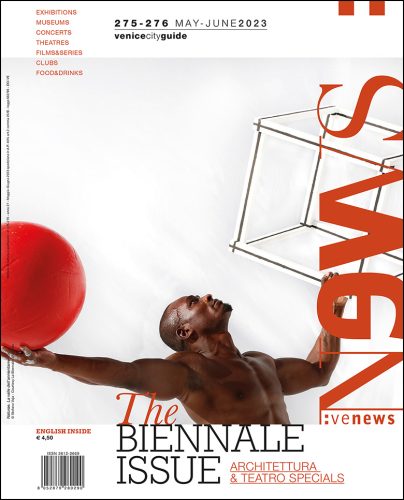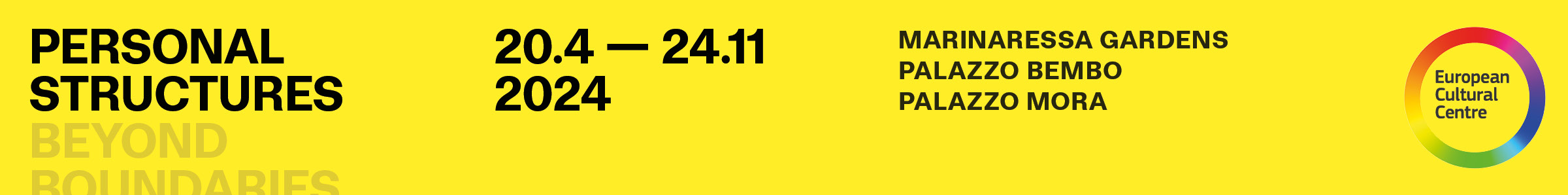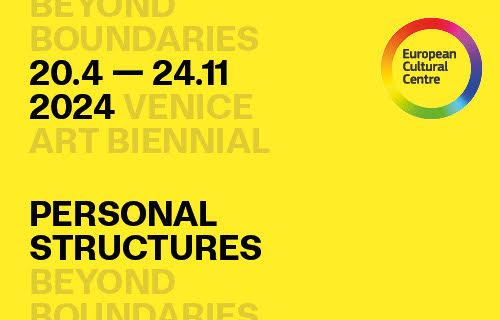PEOPLE
P/REVIEWS
HIGHLIGHTS

FESTA DELLA SENSA 2024
Una festività che si celebra fin dai tempi della Repubblica di Venezia,...

IL FILO DI FAURÉ
In occasione del centenario della morte, Gabriel Fauré viene celebrato ...
-

SALONE NAUTICO 2024
L’Arsenale di Venezia diventa il palcoscenico ideale per accogliere il...
-
STORIES
PEOPLE
P/REVIEWS
STORIES
HIGHLIGHTS

IL FILO DI FAURÉ
In occasione del centenario della morte, Gabriel Fauré viene celebrato da Palazzetto Bru Zane in compagnia degli artisti che sono...
-
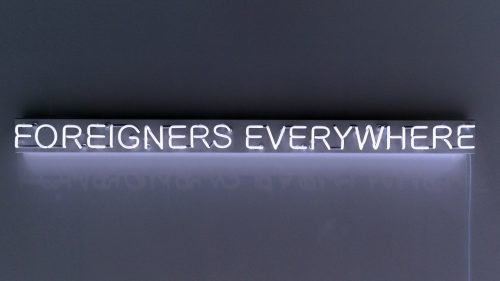
BIENNALE ARTE 2024 – STRANIERI OVUNQUE
Stranieri Ovunque/Foreigners Everywhere, questo il titolo della Biennale Arte 2024, presentata da Roberto Cicutto e Adria...
-

FESTA DELLA SENSA 2024
Una festività che si celebra fin dai tempi della Repubblica di Venezia, in occasione del giorno dell'Ascensione di Cristo (in dia...
CONCERT
Batterista e musicista dalla personalità versatile, Juanma Barroso sarà al Laguna Libre con Francesco Zampini alla chitarra e...
Laguna Libre
CONCERT
Con la sua voce, Yumi Ito crea mondi oltre ogni confine. La cantante svizzera con radici polacco-giapponesi è considerata una ...
TEATRO LA FENICE
WORKSHOP
L’evoluzione dei segni grafici fa da filo conduttore a un appassionante gioco di scoperta: una mappa e alcune schede dida...
Negozio Olivetti
PERFORMANCE
In occasione della mostra Dialoghi Urbani. Street Art vs Museo, M9 – Museo del ’900 invita ogni weekend uno o pi�...
M9 – MUSEO DEL ‘900
CONCERT
L’Auditorium Lo Squero di San Giorgio ha dato il via alla Stagione Concertistica 2024 lo scorso 2 marzo, con appuntamenti pro...
AUDITORIUM LO SQUERO
THE BAG 2024
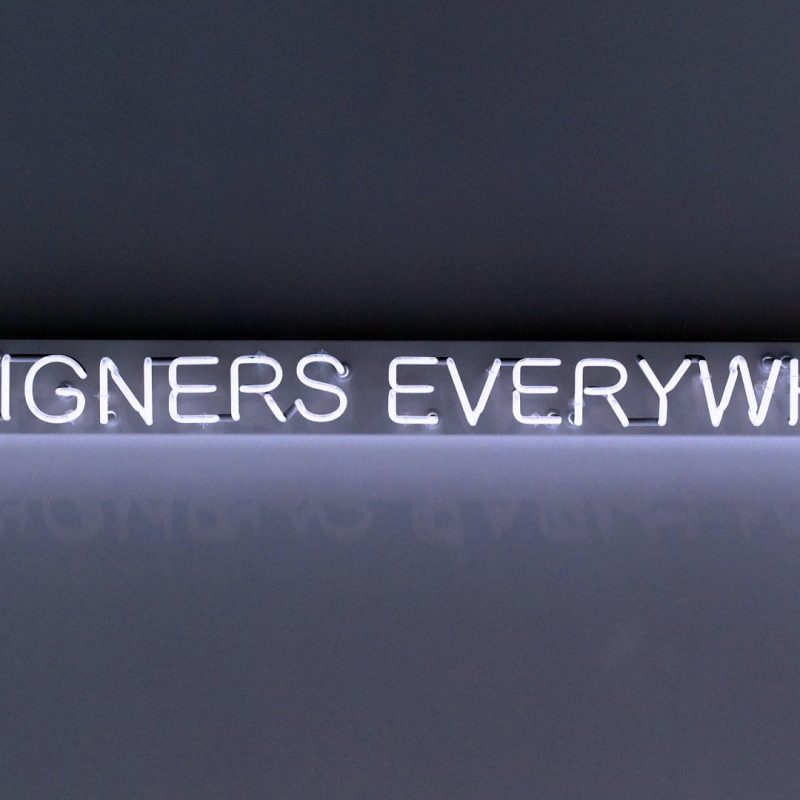
BIENNALE ARTE 2024 – STRANIERI OVUNQUE
Stranieri Ovunque/Foreigners Everywhere, questo il titolo della Biennale Arte 2024, presentata da Roberto Cicutto e Adriano Pedrosa, primo curatore proveniente dall’America Latina alla guida dell’Esposizione.
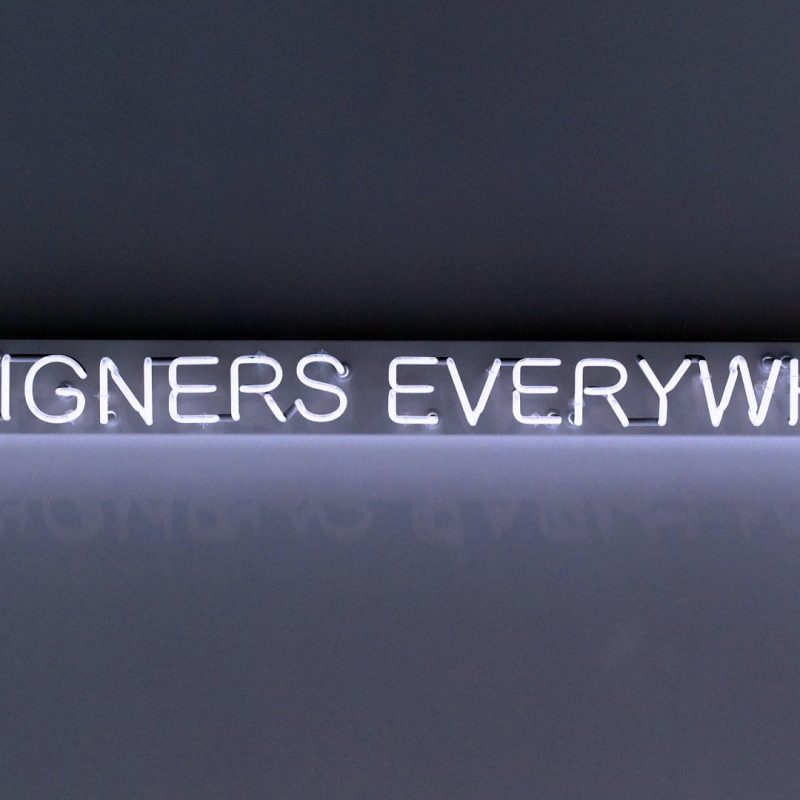
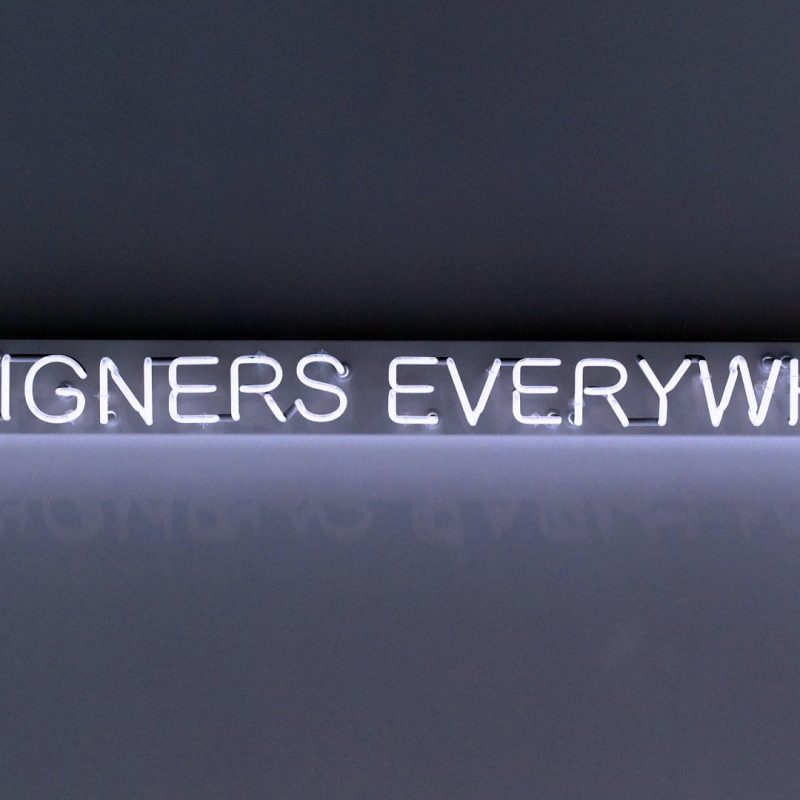
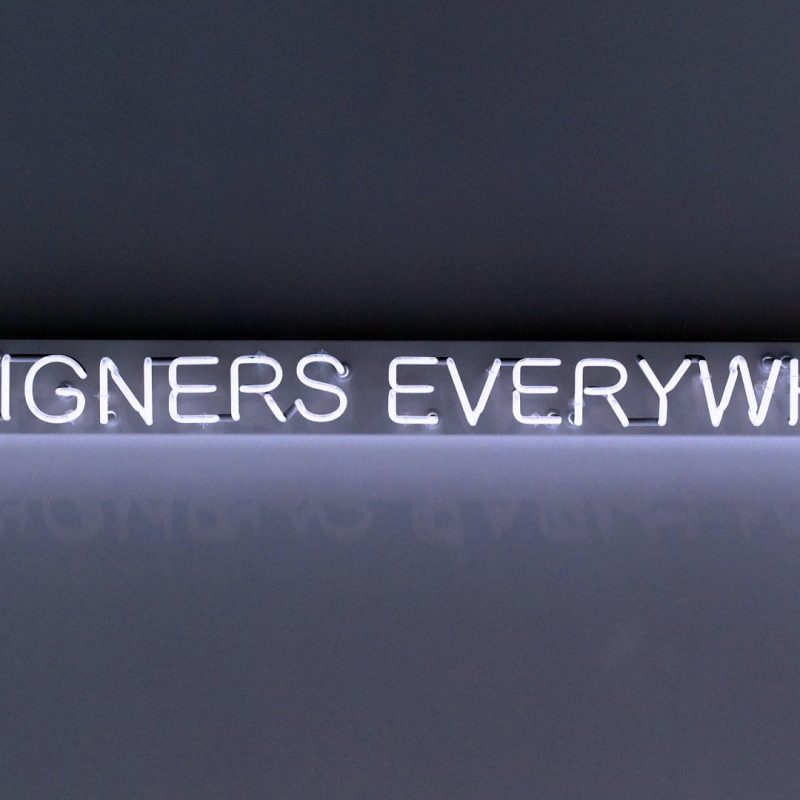



Segnali di continuità
Dal MASP, di cui è direttore dal 2014, a Venezia: il brasiliano Adriano Pedrosa è il primo latino-americano chiamato a guidare la Biennale Arte. Famoso il suo ciclo di Stories su minoranze e realtà locali per il Museo di San Paolo.